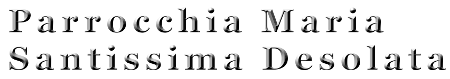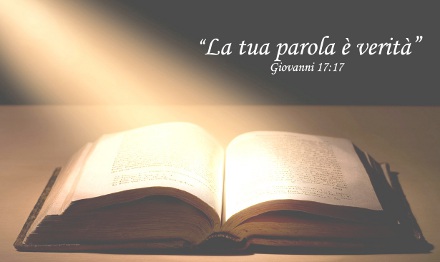|
Gianfranco Ravasi
IL BELLO DELLA BIBBIATratto da Famiglia Cristiana |
Due sapienze a confronto |
|
| Ho qui davanti a me, da un lato, quattro grossi volumi che totalizzano più di 1.500 pagine e, dall’altro, tre volumi altrettanto fitti che trattano lo stesso soggetto: sono due monumentali commenti - l’uno in francese composto dall’esegeta domenicano C. Larcher, e l’altro in italiano, del professore universitario G. Scarpat - dedicati a un libro dell’Antico Testamento di soli 19 capitoli, scritto non in ebraico ma in greco, alle soglie dell’era cristiana, forse ad Alessandria d’Egitto.
È il Libro della Sapienza, un’opera che con molta finezza affronta tre temi: l’immortalità beata del giusto (capitoli 1-5), Ho avuto la fortuna nella mia vita di aver studiato quest’opera biblica sotto la guida di uno dei maggiori studiosi di Platone, il gesuita francese E. Des Places, morto quasi centenario l’anno scorso. Nei suoi corsi egli cercava di mostrare come questo autore sacro, che si era rivestito dei panni ideali di Salomone, considerato il padre della sapienza (cioè della riflessione filosofico-teologica) d’Israele, facesse balenare in filigrana a ogni sua pagina i rimandi o le allusioni alla cultura greca a lui ben nota. |
|
 |
Gianfranco Ravasi
IL BELLO DELLA BIBBIATratto da Famiglia Cristiana |
Nelle mani dell'Onnipotente |
|
| Nei mari estremi è il titolo di un libro autobiografico della scrittrice Lalla Romano apparso nel 1987 e riedito lo scorso anno da Einaudi con un’interessante premessa che, tra l’altro, spiegava anche il valore allusivo di quel titolo. Esso, infatti, ricalca l’equivalente di una novella di Hans Christian Andersen, famoso autore ottocentesco danese di fiabe. In quella novella si giustificava già la vera origine di quel titolo: due marinai, personaggi del racconto, prima di addormentarsi leggono un brano della Bibbia. E una sera s’imbattono nel Salmo 139 (138),9: «... pur nei mari estremi, la Tua mano mi guida, mi sostiene la Tua destra!». Alla fine, quando il sonno avvolge il lettore, «la Bibbia era sotto il capo del marinaio, e la Fede e la Speranza nel suo cuore. Dio era con lui... pur nei mari estremi». Ebbene, il Salmo 139 che invitiamo a cercare nella Bibbia presente in tutte le case dei nostri lettori è un gioiello di grande bellezza e di intensa spiritualità. «Vi si avverte», scriveva ii teologo A.T. Robinson, «il senso miracoloso, avvincente e straordinario di Dio che si proietta in ogni direzione, sopra, sotto, innanzi e indietro». È l’esperienza della presenza totale di Dio, dalla quale è folle fuggire. San Paolo ad Atene, citando il poeta greco Arato di Soli (III sec. a.C.), affermava che «in Lui viviamo, ci muoviamo ed esistiamo» (Atti 17,28). Si inizia celebrando l’onniscienza divina: Dio mi conosce «quando seggo e quando mi alzo, quando cammino e quando sosto», azioni estreme che riassumono tutte le altre. Gli sono familiari anche il pensiero e la mia parola prima ancora che sboccino. Si esalta, poi, l’onnipresenza divina: tutto lo spazio è percorso dal Signore, quello verticale (cielo-inferi) e l’orizzontale (est-aurora e ovest-mar Mediterraneo); anche il tempo con la sua sequenza notte-giorno è perlustrato da Dio, al quale non resiste né la tenebra né la morte. Il salmista si fissa successivamente sulla realtà più stupenda, l’uomo, “prodigio” di Dio. Attraverso il simbolo del vasaio, dello scultore e dei tessitore si dipinge l’azione divina nel segreto del grembo della madre. Il Creatore riesce a scorgere in quell’embrione già tutto il suo destino futuro: «Anche l’embrione i tuoi occhi l’hanno visto», si legge nel versetto 16, «e nel tuo libro erano tutti scritti i giorni che furono formati quand’ancora non ne esisteva uno!». In finale il Salmo esplode in un grido veemente contro i nemici di Dio che si illudono di sfidarlo. Ma il tono globale dell’inno è quello della serenità: si è certi che non si può cader fuori dalle mani dell’Onnipotente. Anche un antico testo aramaico, scoperto a El-Amarna, in Egitto, affermava: «Se noi saliamo in cielo, se noi scendiamo negli inferi, la nostra testa è nelle Tue mani!». |
|
 |
Gianfranco Ravasi
IL BELLO DELLA BIBBIATratto da Famiglia Cristiana |
Ogni cosa ha il suo tempo |
|
| Continuiamo la nostra lettura di Qohelet - Ecclesiaste, un libro biblico dalla bellezza tenebrosa e inquietante. Delle sette malattie dello spirito che egli sembra presentarci già tre sono sfilate davanti a noi: quelle del parlare, dell’agire e del sapere. Quarta malattia: intacca l’essere intero, cioè quel cosmo e quella storia sui quali il sapiente biblico tradizionale si gettava con grande passione, convinto di poterli penetrare, studiare, plasmare. Cominciamo con la natura, per scoprire come la considerava Qohelet. È una strofa di grande bellezza, “una perla del libro”, secondo la definizione di uno studioso, Thomas K. Cheyne. Leggiamola: «... La terra è eternamente ferma. Sorge il sole; tramonta il sole affannandosi verso quel luogo da cui rispunterà. Soffia il vento dal sud, gira a settentrione, passa girando e rigirando il vento e sui suoi giri ritorna il vento. Tutti i fiumi scorrono verso il mare, eppure mai il mare si colma; alla foce scorrono i fiumi e di là essi riprendono a scorrere» (1,4-7). E dopo la natura, la storia. Il rimando classico è a una delle pagine più popolari di Oohelet. Essa è potente nella sua povertà stilistica, affidata all’arida e litanica brutalità del parallelismo ripetuto in modo rigido, vero e proprio rosario di «tempi e stagioni» (3,1-9). Su un asse predeterminato ruota il disco uniforme degli eventi, il suo inesorabile svolgersi è monotono come un suono ripetuto, è implacabile come il fluire di una colata, è stridente come un intervento di demolizione. Su questo gorgo circolare “infinito” si leva la domanda radicale: Che valore ha tutto ciò? |
|
 |
Gianfranco Ravasi
IL BELLO DELLA BIBBIATratto da Famiglia Cristiana |
L'inverno dell'esistenza |
|
| Ritorniamo anche questa volta sul libro di Qohelet - Ecclesiaste. L’abbiamo esaminato quasi come fosse una diagnosi su sette malattie dell’esistenza. Già abbiamo visto le crisi della parola, dell’azione, della sapienza, della storia. Quinta malattia è quella che intacca la società: «Io mi sono messo a considerare tutte le violenze perpetrate sotto il sole: ecco le lacrime delle vittime da nessuno consolate, da nessuno consolate contro il forte potere dei violenti» (4,1). La sesta malattia è quella che infetta la stessa esistenza umana ed è dipinta in una delle pagine poeticamente più alte ove Qohelet coglie la vita dall’angolo di visuale del tramonto, cioè della vecchiaia (si legga integralmente il testo di Qohelet da 11,7 a 12,7). Una coltre di tenebra avvolge tutto lo spazio e tutto il tempo: è l’immagine di un inverno senza sole che non ha mai fine, sono giorni di vita che non si ha voglia di assaporare perché fanno nausea. L’inverno è la stagione più vera dell’uomo, quella che ne definisce meglio la qualità e il senso. In questo disegno del castello in sfacelo cui seguirà quello della campagna circostante e dei segni della morte si cela un’evidente allusione al corpo dell’uomo che sta avvicinandosi alla polvere per dissolversi in essa: “i guardiani della casa” sono le braccia, “gli uomini forti” le gambe, “le macinatrici” i denti, le donne che guardano dalle inferriate gli occhi, lo spegnersi dei canti la sordità |
|
 |
Gianfranco Ravasi
IL BELLO DELLA BIBBIATratto da Famiglia Cristiana |
Niente di nuovo sotto il sole |
|
| È certamente la proposta di lettura biblica più ampia tra quelle finora suggerite in questa rubrica. La stiamo dedicando già dalla scorsa settimana a Qohelet - Ecclesiaste, il sapiente dell’Antico Testamento che fa balenare idealmente davanti ai nostri occhi sette malattie dello spirito che sono ancor oggi attuali. La prima riguarda il linguaggio: «Tutte le parole sono logore e l’uomo non può più usarle» (1,8). L’idea è straordinariamente moderna, se pensiamo all’attuale crisi del linguaggio, alle parole “malate”, a quelle “nere”, cioè prive di senso e abusate, alle ragnatele della chiacchiera e dei luoghi comuni. In ebraico, però, considerata l’efficacia del termine, debarim, “parole”, significa anche “fatti”: le cose sono stanche, si disfanno, «tutto nella vita diventa logoro: parole e situazioni. La seconda malattia è quella del fare o, come ama dire Qohelet, dell’amai, del “faticare”, per cui il lavoro è labor, cioè “fatica”, alienazione, travaglio (il travail francese!). Siamo ben lontani dall’entusiasmo mostrato dalla sapienza biblica tradizionale nel descrivere le capacità eccezionali dell’uomo lavoratore. La domanda d’avvio del libro è lapidaria: «Quale valore ha tutta la fatica che affatica l’uomo sotto il sole?» (1,3). Sembra di sentire il Petrarca del Trionfo della morte: «O ciechi, e il tanto affaticar che giova?». Di nuovo in 2,18: «Io ho in odio ogni fatica di cui io ho faticato sotto il sole», parole messe in bocca a Salomone! E poche righe dopo: «Io ho il cuore invaso dalla disperazione per tutta la fatica con cui ho faticato sotto il sole» (2,20), fatica destinata a dissolversi nello spreco degli eredi. E ancor più forte la domanda diviene in 5,15: «Che valore ha faticare per il vento?». A confessarlo è Salomone, delle cui spoglie si ammanta Qohelet, che aveva fatto «opere magnifiche, si era eretto palazzi, si era piantato vigne, preparato giardini e parchi, piantandovi alberi dai mille frutti, si era scavato canali d’acqua per irrigare quelle piantagioni lussureggianti, si era allevato mandrie di buoi e di pecore più numerose di tutte quelle dei suoi predecessori in Gerusalemme, aveva accumulato anche argento e oro, tesori di regni e di province» (2,4-8). Terza malattia: la crisi dell’intelligenza. Qohelet è un sapiente, uno scriba, un intellettuale, come dice anche l’epigrafe finale (12,9-10), disprezza la stupidità; per ben ottantacinque volte introduce le sue riflessioni in prima persona, consapevole di una sua originalità di pensiero. Eppure il risultato finale del conoscere è amaro: «La mia mente è penetrata profondamente nella sapienza e nella scienza. Sì, la mia mente è penetrata nella sapienza e nella scienza, nella follia e nella stupidità e ho capito che anche questo è fame di vento. Infatti, grande sapienza è grande tormento; chi più sa più soffre»(1,16-18). |
|