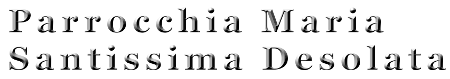| I. IL TEMPO DI QUARESIMA | II. LE LETTURE BIBLICHE DELLA QUARESIMA. |
| III. NORME LITURGICHE | IV. RACCOMANDAZIONI E SUGGERIMENTI |
| V - NORME LITURGICHE COMPLEMENTARI | 5. ASTINENZA E DIGIUNO |
I. IL TEMPO DELLA QUARESIMA
1. Un tempo dalle caratteristiche proprie.
La Quaresima è il tempo che precede e dispone alla celebrazione della Pasqua. Tempo d’ascolto della Parola di Dio e di conversione, di preparazione e di memoria del Battesimo, di riconciliazione con Dio e coi fratelli, di ricorso più frequente alle "armi della penitenza cristiana": la preghiera, il digiuno e l'elemosina (vedere Mt 6,1-6.16-18).
A somiglianza dell'antico popolo d'Israele che camminò per quarant’anni nel deserto per essere pronto ad entrare nella terra promessa, la Chiesa, il nuovo popolo di Dio, si prepara per quaranta giorni per celebrare la Pasqua del Signore. Pur essendo un tempo penitenziale, non è un tempo triste e opprimente. Si tratta di un tempo speciale di purificazione e di rinnovamento della vita cristiana, per poter condividere in maggior pienezza e gioia il mistero pasquale del Signore.
La Quaresima è un tempo privilegiato per intensificare il percorso della propria conversione. Questa strada suppone la cooperazione con la grazia, per far morire l'uomo vecchio che agisce in noi. Si tratta di rompere col peccato che abita nel nostro cuore, di allontanarci da tutto quello che ci porta lontano dal Piano di Dio, e quindi, dalla nostra felicità e realizzazione personale.
La Quaresima è una dei quattro tempi forti dell'anno liturgico e questo va colto in modo chiaro in ognuno dei dettagli della sua celebrazione. Quanto più accentueremo le sue particolarità, più fruttuosamente potremo vivere tutta la sua ricchezza spirituale.
Pertanto bisognerà sforzarsi, tra l’altro:
-
di far capire che in questo tempo è diversa la prospettiva sia delle letture bibliche (nella messa non c'è più la lettura continuata), come dei testi ecologici (propri e quasi sempre obbligatori per ognuna delle celebrazioni).
-
Che i canti siano totalmente diversi da quelli soliti e riflettano la spiritualità penitenziale, propria di questo tempo.
-
di ottenere un'ambientazione sobria ed austera che rifletta il carattere di penitenza della Quaresima.
2. Senso della Quaresima.
La prima cosa che dobbiamo dire riguardo alla finalità della Quaresima è che è un tempo di preparazione alla Pasqua. Per questo, di solito, la Quaresima è definita "cammino verso la Pasqua". La Quaresima non è quindi un tempo fine a se stesso, o un tempo "forte" o importante in se stesso.
È piuttosto un tempo di preparazione, ed un tempo "forte" in quanto prepara un tempo ancora "più forte" che è la Pasqua. Il tempo di Quaresima come preparazione alla Pasqua si basa su due pilastri: da un lato, la contemplazione della Pasqua di Gesù; e d'altro, la partecipazione personale alla Pasqua del Signore attraverso la penitenza e la celebrazione o preparazione dei sacramenti pasquali - battesimo, confermazione, riconciliazione, eucaristia -, coi quali incorporiamo la nostra vita alla Pasqua del Signore Gesù.
Incorporarci al "mistero pasquale" di Cristo suppone partecipare al mistero della sua morte e resurrezione. Non dimentichiamo che il Battesimo ci configura alla morte e resurrezione del Signore. La Quaresima cerca di fare in modo che quella dinamica battesimale (morte per la vita) sia vissuta più profondamente. Si tratta allora di morire al nostro peccato per resuscitare con Cristo alla vera vita: "Io vi assicuro che se il grano di frumento… muore darà molto frutto" (Gv 20,24).
A questi due aspetti bisogna aggiungere poi un'altra sfumatura più ecclesiale: la Quaresima è il tempo adatto per curare la catechesi e la preghiera dei bambini e dei giovani che si preparano alla confermazione e alla prima comunione; e perché tutta la Chiesa preghi per la conversione dei peccatori.
3. Livelli del tempo di Quaresima.
Per poter vivere adeguatamente la Quaresima è necessario conoscere bene i diversi livelli sui quali si muove questo tempo.
Innanzi tutto, bisogna distinguere la "Quaresima domenicale", col suo dinamismo proprio ed indipendente, dalla "Quaresima feriale".
a. La "Quaresima domenicale"
In essa si distinguono diversi blocchi di letture. Inoltre, all'insieme delle prime cinque domeniche che formano come un'unità, si contrappone l'ultima domenica - domenica delle Palme nella Passione del Signore - che forma piuttosto un tutt’uno con le ferie della Settimana Santa, e perfino col Triduo Pasquale.
b. La "Quaresima feriale"
In essa vanno segnalati due momenti distinti:
-
quello delle ferie delle prime quattro settimane, centrate soprattutto sulla conversione e la penitenza.
-
e quello delle ultime due settimane, nelle quali, ai suddetti temi, si affianca la contemplazione della Passione del Signore, che diventerà ancora più intensa nella Settimana Santa.
Organizzando, dunque, le celebrazioni feriali, bisognerà distinguere queste due tappe, sottolineando nella prima gli aspetti di conversione (le orazioni, i prefazi, le preci ed i canti della messa aiuteranno in questo).
A partire dal lunedì della Vª settimana, siccome cambia un po' la prospettiva, centrando più l'attenzione nella croce e nella morte del Signore (sono soprattutto le orazioni della messa e il I° prefazio della Passione del Signore, hanno questa nuova prospettiva).
In fondo, c'è qui una visione teologica molto interessante: la conversione personale che consiste nel passare dal peccato alla grazia (santità), si realizza sempre di più, con un "crescendo" intenso, nella Pasqua del Signore: è solo nella persona del Signore Gesù, nostro capo, che la Chiesa, suo corpo mistico, passa dalla morte alla vita.
Diciamo, per concludere, che sarebbe molto opportuno evidenziare con maggiore intensità le ferie dell'ultima settimana di Quaresima - la Settimana Santa - nelle quali la contemplazione della croce del Signore diventa quasi esclusiva (Prefazio II° della Passione del Signore). Per ciò, sarebbe molto conveniente che, in quest’ultima settimana si evidenziassero alcuni segni straordinari che sottolineassero l'importanza di questi ultimi giorni. Sebbene le rubriche indicano alcuni di questi segni (in questi giorni non è ammessa, per esempio, nessun’altra celebrazione, anche se si trattasse di solennità), a questi segni bisognerebbe aggiungerne altri di più facile comprensione per i fedeli, così da evidenziare meglio il carattere di massima importanza che hanno questi giorni (per esempio il canto dell'acclamazione al vangelo; la benedizione solenne quotidiana alla fine della messa; l’uso di paramenti violacei più solenni, etc.).
4. Il luogo della celebrazione.
Va ricercata la maggior austerità possibile, tanto per l'altare, come per il presbiterio e gli altri luoghi ed elementi celebrativi. Va conservato solo quello che è necessario perché il luogo risulti accogliente ed ordinato. L'austerità con cui si presenta in questi giorni la chiesa (il tempio), in contrapposizione col tono festivo con cui si celebrerà la Pasqua ed il tempo pasquale, aiuterà a cogliere il senso di "passaggio" (pasqua = passaggio) che hanno le celebrazioni di questo ciclo.
Durante la Quaresima bisogna, dunque, eliminare i fiori (che possono essere sostituiti da piante ornamentali,) i tappeti non necessari, la musica strumentale, a meno che sia indispensabile per un buon canto. Una pratica che in alcune chiese potrebbe essere espressiva è quella di ricoprire l'altare, al di fuori della celebrazione eucaristica, con un panno di tessuto viola.
La stessa austerità va applicata anche al luogo del tabernacolo ed alla benedizione col Santissimo, perché ci deve essere una gran coerenza tra il culto che si dà al Santissimo e la celebrazione della messa. La stessa coerenza ci deve essere anche tra liturgia e pietà popolare. Non ci sarà, dunque, nessun elemento festivo, durante i giorni quaresimali e della Settimana Santa, né sull'altare della riserva eucaristica né nell'esposizione del Santissimo.
5. Solennità, feste e memorie durante la Quaresima.
Un altro punto da curare è il modo di celebrare le feste dei Santi durante la Quaresima. Quello che più conta è fare in modo che la Quaresima non sia oscurata da celebrazioni estranee ad essa. Proprio per questo, il Calendario romano ha cercato di togliere da questo tempo le celebrazioni dei santi.
In realtà durante tutto il lungo periodo quaresimale, si celebrano solo quattro festività (oltre a qualche solennità o festa dei calendari particolari): Santi Cirillo e Metodio (14 febbraio); la Cattedra di San Pietro (22 febbraio); San Giuseppe (19 marzo) e l'Annunciazione del Signore (25 marzo). In ogni caso nel modo di celebrare queste feste non si dovrà dare l'impressione che si "interrompe la Quaresima"; piuttosto bisognerà inserire queste feste nella spiritualità e nella dinamica di questo tempo liturgico.
Rispetto alla memoria dei santi, bisogna ricordare che durante la Quaresima si possono celebrare; se si celebrano, però, lo si deve fare con paramenti violacei e nel modo indicato dalle norme liturgiche.
II. LE LETTURE BIBLICHE DELLA QUARESIMA.
1. Visione d’insieme.
Fin dall’inizio è opportuno segnalare il fatto che in questo tempo la tematica dei diversi cicli di letture è molto più variegata che negli altri tempi liturgici. Anche se, nel Lezionario, tutti i vari momenti di questo tempo hanno un sfondo comune, il rinnovamento della vita cristiana attraverso la conversione, questa tematica si presenta sotto ottiche molto diverse, ognuna delle quali ha le sue sfumature proprie e distinte. Se questa diversità non si tiene in considerazione, se si riduce l'insieme ad una tematica unica, molte tematiche presenti nelle letture liturgiche passeranno, praticamente, inosservate; fenomeno questo che, purtroppo, succede spesso.
Va, dunque, sottolineato innanzi tutto che la caratteristica principale delle letture di Quaresima non poggia tanto sulla "novità" di alcune letture che si scoprono grazie ai lezionari post-conciliari, quanto nell'abbondanza di linee concomitanti che è necessario unire spiritualmente, in modo che ognuna di esse apporti il suo contributo al rinnovamento quaresimale di chi usa i citati lezionari.
L'atteggiamento fondamentale, di fronte alle letture quaresimali, deve essere, soprattutto, quello di un ascolto tranquillo e penetrante che aiuti lo spirito a impregnarsi sempre più dei criteri della fede, a volte abbastanza conosciuti, ma non sufficientemente interiorizzati e resi vitali.
Non si tratta di "meditazioni" più o meno intellettuali, ma di una contemplazione "gioiosa" del Piano di Dio sulla persona umana e la sua storia, e di un ascolto attento della chiamata di Dio ad una conversione che ci porti alla pace e alla felicità.
Nell'insieme delle Letture quaresimali si colgono con facilità alcune linee di forza sulle quali deve incentrarsi la conversione quaresimale. Questa conversione non la si può ridurr ad un puro miglioramento morale. È piuttosto una conversione radicale a Cristo, l'Uomo nuovo, per vivere in Lui (vedere Col 2,7).
Queste le linee di forza:
a. La meditazione sulla storia della salvezza, realizzata da Dio-amore in favore della persona umana creata a sua immagine e somiglianza. Dobbiamo "convertirci" da una vita egoistica, che vede l'essere umano rinchiuso nel suo errore esistenziale, ad una vita di comunione col Signore, Via, Verità e Vita, che ci porta al Padre nello Spirito Santo.
b. Il mistero pasquale vissuto come culmine di questa storia sacra: dobbiamo "convertirci" dalla visione di un Dio comune ad ogni essere umano, alla visione del Dio vivo e vero che si è rivelato pienamente nel suo unico Figlio Gesù Cristo e nella sua vittoria pasquale presente nei sacramenti della sua Chiesa: "Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna"(Gv 3,16).
c. Il combattimento spirituale, che esige la cooperazione attiva con la grazia per far morire l'uomo vecchio ed il proprio peccato e cedere il passo alla realtà dell'uomo nuovo in Cristo. In altre parole, la lotta per la santità, esigenza che nasce dal nostro Battesimo.
Queste tre linee devono essere proposte tutte insieme. La prima linea di forza - la meditazione della Storia della Salvezza - l'abbiamo principalmente nelle letture dell'Antico Testamento delle domeniche e nelle letture della Veglia Pasquale. La seconda - il mistero pasquale vissuto come culmine della storia sacra -, nei vangeli delle domeniche III, IV e V (i sacramenti pasquali) e, in un certo qual modo, nei vangeli feriali a partire dal lunedì della IV settimana (opposizione di Gesù al male - "i giudei" - che si conclude con la vittoria pasquale di Gesù sulla morte, male supremo). La terza linea - il combattimento spirituale, la vita in Cristo, la vita virtuosa e santa - appare particolarmente nelle letture apostoliche delle domeniche e nell'insieme delle letture feriali della messa delle prime tre settimane.
Vale la pena sottolineare che le tre linee di forza che stiamo esponendo si trovano, con maggiore o minore intensità, a portata di tutti i fedeli: di coloro che partecipano abitualmente alla messa domenicale come di coloro che prendono parte anche all'eucaristia dei giorni feriali. Con intensità diversa, ma con un contenuto fondamentalmente identico, attraverso la liturgia quaresimale tutti i fedeli possono bere ad una fonte che invita alla conversione sotto tutti i suoi aspetti.
2. Messe domenicali.
Le letture domenicali di Quaresima hanno un'organizzazione unitaria che deve essere tenuta presente nella predicazione.
Le letture dell'Antico Testamento seguono la una propria linea che non ha una relazione diretta coi vangeli, a differenza del resto dell'anno. Una linea importante per comprendere la Storia della Salvezza.
Anche i Vangeli seguono anche una tematica organizzata tutta loro.
Le letture apostoliche, invece, sono state pensate come complementari alle precedenti.
a. La prima lettura ha, in questo tempo di Quaresima, un'intenzione chiara: presentare i grandi temi della Storia della Salvezza, per preparare il grande avvenimento della Pasqua del Signore:
-
La creazione ed origine del mondo (prima domenica).
-
Abramo, padre dei credenti (seconda domenica).
-
L'Esodo e Moisè (terza domenica).
-
La storia d'Israele, centrata soprattutto su Davide (quarta domenica).
-
I profeti ed il loro messaggio (quinta domenica).
-
Il Servo di Yahvé (domenica delle Palme).
Queste tappe si proclamano più direttamente nell’Anno A, nei loro momenti culminanti.
L’Anno B si incentra soprattutto sul tema dell'Alleanza (con Noè, con Abramo, con Israele, l'esilio, la nuova alleanza annunciata da Geremia).
Nell’Anno C, le stesse tappe sono viste sotto l’aspetto del culto (offerta delle primizie, celebrazione della Pasqua, etc.).
Nella sesta domenica, o domenica delle Palme nella Passione del Signore, invariabilmente si proclama il canto del Servo di Yahvé, di Isaia.
Queste tappe rappresentano un ritorno alla fonte: la storia delle attuazioni salvifiche di Dio che preparano l'avvenimento centrale: il mistero Pasquale del Signore Gesù. Nella predicazione bisogna tenere in conto questa progressione, per non perdere di vista il cammino verso la Pasqua.
b. Anche la lettura evangelica è sempre indipendente nelle sei settimane:
-
Prima domenica: il tema delle tentazioni di Gesù nel deserto, lette secondo la prospettiva dell’evangelista dell’anno; il tema dei quaranta giorni, il tema del combattimento spirituale.
-
Seconda domenica: la Trasfigurazione, letta anche questa in base all’ottica dell’evangelista dell’anno; di nuovo il tema dei quaranta giorni (Mosè, Elia, Cristo) e la preparazione pasquale; la lotta e la tentazione portano alla vita.
-
Terza, quarta e quinta domenica: presentazione dei temi catequetici dell'iniziazione cristiana: l'acqua, la luce, la vita.
Nell’Anno A: i grandi temi battesimali di San Giovanni: la samaritana (acqua), il cieco (luce), Lazzaro (vita).
Nell’Anno B: temi paralleli, ancora di San Giovanni: il Tempio, il serpente e Gesù Servo.
Nell’Anno C: temi di conversione e misericordia: iniziazione ad un altro Sacramento quaresimale-pasquale: la Penitenza.
-
Sesta domenica: la Passione di Gesù, ogni anno secondo il proprio evangelista (riservando la Passione di San Giovanni al venerdì Santo).
Il predicatore deve tener presente quest’unità ed aiutare la comunità ad approfondire i diversi aspetti del suo itinerario verso la Pasqua (non rimanendo, per esempio, fermi al tema della tentazione o della penitenza, ma entrando anche nei temi battesimali: Cristo e la sua Pasqua sono per noi la sorgente dell'acqua viva, della luce vera e della nuova vita).
c. La seconda lettura è pensata come complemento dei grandi temi della Storia della Salvezza e della preparazione evangelica alla Pasqua. Temi spirituali, relativi al processo di fede e conversione ed alla concretizzazione morale dei temi quaresimali: la fede, la speranza, l'amore, la vita spirituale, figli della luce, etc.
3. Messe feriali.
Questo gruppo di letture ha grande peso nella vita spirituale di quei cristiani che sogliono partecipare attivamente all'eucaristia quotidiana. È giusto segnalare che il lezionario feriale di Quaresima si andò formando durante vari secoli e prima della riforma conciliare era già il più ricco di tutto l'anno liturgico. La riforma liturgica lo rispettò per la sua antica tradizione e ricchezza. Essendo stato costruito lungo i secoli, le sue tematiche sono piuttosto varia e non offrono quindi la possibilità di una lettura continua o un secondo un progetto d’insieme secondo il metodo al quale ci hanno abituato i lezionari usciti dalla riforma conciliare.
L'attuale lezionario feriale della messa divide la Quaresima in due parti: da una parte, abbiamo i giorni che vanno dal mercoledì delle Ceneri fino al sabato della IIIª settimana; e dall’altra, le ferie che vanno dal lunedì della IVª settimana fino al principio del Triduo Pasquale.
1. Nella prima parte della Quaresima (mercoledì delle Ceneri - sabato della IIIª settimana), le letture continuano a presentare, positivamente, gli atteggiamenti fondamentali del vivere cristiano e, negativamente, la riforma dei difetti che frenano la nostra sequela di Gesù.
In queste ferie, entrambe le letture normalmente hanno un’unità tematica abbastanza marcata, che insiste su temi come la conversione, il senso del tempo quaresimale, l'amore al prossimo, la preghiera, l'intercessione della Chiesa per i peccatori, l'esame di coscienza, etc.
Quando si è iniziato a organizzare la Quaresima, c'era messa, oltre alla domenica, solo nei giorni di mercoledì e venerdì. Per questo motivo il lezionario di Quaresima privilegia le letture di questi due giorni con letture di maggiore importanza che quelle delle restanti ferie. Dette letture normalmente sono relative alla passione e alla conversione.
2. nella seconda parte della Quaresima, (a partire dal lunedì dell'IVª settimana fino al Triduo Pasquale), il lezionario cambia prospettiva: ci offre una lettura continuata del vangelo secondo San Giovanni, scegliendo soprattutto i brani nei quali si coglie l'opposizione crescente tra Gesù ed i "giudei".
Questa meditazione del Signore che si confronta col male, personalizzato, nel vangelo di Giovanni, dai "giudei", vuole portare la lotta quaresimale non solo su un piano ascetico, ma, soprattutto, nel contesto della comunione con Cristo, l'unico vincitore assoluto del male.
In queste ferie, le letture non sono particolarmente legate tematicamente l’una all'altra, ma presentano, in maniera indipendente, da una parte la figura del Servo di Yahvé o di un altro personaggio (Geremia specialmente) visti come immagine e profezia del Salvatore crocifisso; e, dall’altra, lo sviluppo della trama che culminerà nella morte e vittoria di Cristo.
Infine, è opportuno ricordare che a partire dal lunedì della IV settimana appare un tema forse non molto conosciuto: l'insieme dinamico che, partendo delle "opere" e "parole" del Signore Gesù, arriva fino all'avvenimento della sua "ora". Per non pochi può essere consigliabile fare lo sforzo di meditare in modo continuato questi vangeli nel loro svolgimento progressivo. Questo tema può risultare molto arricchente. Benché spesso si conoscano i testi, poche volte, però, si è scoperto il significato dinamico che unisce l'insieme di queste letture, un insieme che sfocia nell’ "ora" di Gesù, nella sua glorificazione attraverso la morte che celebriamo nel Triduo pasquale.
III. LE NORME LITURGICHE.
1. Le celebrazioni nel loro insieme.
Si omette sempre il "Alleluia" in ogni celebrazione.
Dalla chiesa vanno tolte le decorazioni e i fiori, eccetto nella IV domenica (Domenica della gioia nel nostro cammino verso la Pasqua). Si sopprime pure la musica strumentale (eccetto la IV domenica), a meno che sia indispensabile per accompagnare qualche canto.
La stessa austerità si avrà anche nei confronti dell'altare con il Tabernacolo e nelle celebrazioni extraliturgiche e nelle manifestazioni della pietà popolare.
2. Rispetto alle celebrazioni dell'eucaristia.
Eccetto nelle domeniche e nelle solennità e feste che hanno il prefazio proprio, negli altri giorni si dice uno dei cinque prefazi di Quaresima.
Le domeniche si omette l'inno della "Gloria". Quest’inno, invece, si dice nelle solennità e feste.
Prima della proclamazione del vangelo, tanto nelle messe della domenica come nelle solennità, feste e ferie, il canto del "Alleluia" si sostituisce con un’altra acclamazione a Cristo. E per sottolineare meglio la distinzione tra le ferie ed i giorni festivi, crediamo sia meglio omettere sempre questo canto nei giorni feriali. Addirittura, nelle domeniche è meglio omettere questa acclamazione che recitarla solamente.
La domenica non si può celebrare nessuna altra messa che non sia quella del giorno. Nelle ferie, quando il Calendario Liturgico lo permette, esiste la possibilità di celebrare una messa diversa da quella del giorno. Se nelle ferie si vuole fare la memoria di un santo, si sostituisce la colletta del giorno con quella del santo. Gli altri elementi devono essere della feria, comprese la preghiera sulle offerte e quella dopo la comunione.
IV. RACCOMANDAZIONI E SUGGERIMENTI.
1. testi eucologici.
La Quaresima è il tempo dell'anno che possiede la maggior ricchezza di testi ecologici (l’insieme di preghiere di un libro liturgico o di una celebrazione). La messa non ha propria solo la prima orazione di ogni giorno, ma anche la preghiera sulle offerte e quella la comunione. Ma, oltre a questi testi obbligatori, vorremmo sottolineare l'importanza di altri formulari che si possono usare liberamente:
a. L'atto penitenziale della messa.
Durante questo tempo sarebbe raccomandabile valorizzare questa parte della celebrazione. Le invocazioni, per esempio, potrebbero essere variate ogni giorno della settimana (il Messale Romano offre in questo caso una varietà di possibilità), e cantare ogni giorno - non limitarsi a pregare - il "Signore, pietà". È un modo semplice di sottolineare il carattere penitenziale di questi giorni.
b. Preghiera dei fedeli.
Sarebbe opportuno usare alcuni formulari particolarmente rispondenti al significato proprio di questo tempo, nei quali aggiungere alcune invocazioni per i peccatori, secondo quanto è detto al riguardo nel Concilio Vaticano II (vedere Sacrosanctum Concilium N. 109). Ugualmente, assecondando la richiesta del Papa, si possono includere invocazioni per la pace del mondo, per la famiglia, per la difesa della vita, e per le vocazioni.
c. Prefazi.
Nell'anno A, tutte le domeniche hanno un prefazio proprio collegato al vangelo del giorno. Negli anni B e C, hanno prefazio proprio le domeniche Iª e IIª e la domenica delle Palme. Le restanti domeniche si usa uno dei prefazi comuni di Quaresima. Il più appropriato per la domenica IVª è il prefazio I°, per le sue allusioni alla Pasqua che si avvicina. Invece il prefazio IV° per le sue allusioni al digiuno, non è appropriato per la domenica.
Per i giorni feriali ci sono cinque prefazi. Tutti questi Si farà in modo di utilizzarli tutti, in modo da poter godere spiritualmente del loro contenuto. Per il suo carattere penitenziale, il IV° è particolarmente indicato per i venerdì.
c. 1 Lo spirito della Quaresima nei suoi Prefazi.
L'ultima edizione di Messale Romano (1988), riporta cinque Prefazi di Quaresima, destinati alle quattro prime settimane di questo tempo.
La settimana Vª e VIª, come si ricorderà, dispongono di due Prefazi della Passione del Signore.
I cinque prefazi quaresimali sono queste:
-
Prefazio I: Significato spirituale della Quaresima.
Da usarsi soprattutto la domenica, quando non c'è un prefazio proprio.
Questo prefazio presenta quattro idee portanti:
In primo luogo definisce l'atteggiamento del cristiano in quaresima: "prepararsi ogni anno con gioia alla celebrazione della Pasqua". Questo prefazio presenta la meta positiva del processo quaresimale e della vita cristiana: partecipare in pienezza al mistero pasquale del Signore Gesù. Quello che desideriamo e celebriamo è il mistero di Cristo rinnovato nella nostra vita; la Chiesa che si incorpora alla Pasqua del suo Signore.
Un secondo aspetto: il compito quaresimale è descritto con tre pennellate: è quello di liberarci dal peccato e purificarci interiormente; di dedicarci con maggiore impegno alla lode divina (vita di preghiera); e, infine, di vivere più intensamente l'amore fraterno, la carità.
Il terzo aspetto sottolinea che la meta ultima alla quale tende il processo quaresimale è "arrivare ad essere in pienezza figli di Dio", in Cristo, il Figlio per eccellenza, nel quale siamo stati innestati per mezzo del Battesimo.
Infine, un quarto aspetto: il prefazio sottolinea che tutto è iniziativa divina, alla quale la persona umana deve corrispondere in base a tutte le sue possibilità o capacità: "in Cristo tu doni ogni anno ai tuoi fedeli di prepararsi con gioia..." La Parola di Dio ed i Sacramenti c'aiutano nel nostro cammino verso la santità.
-
Prefazio II: La penitenza dello spirito.
Da usare soprattutto la domenica, quando non è indicato un prefazio proprio.
Questo prefazio sottolinea il senso della penitenza quaresimale. La Quaresima è presentata come un tempo di grazia (tempo di misericordia) che Dio ci offre per ottenere la purificazione interna dello spirito. La grazia di Dio ci libera dal peccato, dai nostri vizi e dalle nostre schiavitù; mette ordine nelle nostre potenzialità e passioni; ci insegna ad usare i beni materiali come mezzi e non come fini; ci aiuta comprendere la loro caducità e quindi a non attaccarci disordinatamente ad essi. Questo è il senso della penitenza quaresimale: cambiamento di mentalità (metanoia), spogliarsi dell'uomo vecchio per rivestirsi dell'uomo nuovo.
-
Prefazio III: I frutti delle privazioni volontarie.
Da usarsi durante le ferie ed i giorni di astinenza e digiuno.
Questo prefazio precisa ancora di più questa "penitenza" e indica il perché dell'astinenza e del digiuno. Il digiuno ha una doppia finalità: da un lato quella di mitigare i nostri appetiti disordinati, e dall'altra di alleviare le necessità del prossimo col frutto della nostra rinuncia. Con ciò diamo grazie a Dio e ci facciamo discepoli e strumenti del suo amore.
-
Prefazio IV: I frutti del digiuno.
Da usarsi durante le ferie ed i giorni di astinenza e digiuno.
È il più antico dei prefazi quaresimali. Si limita a sottolineare il digiuno come elemento centrale della Quaresima, presentandoci l'aspetto "ascetico" di questo tempo liturgico.
-
Prefazio V: La via dell'esodo nel deserto quaresimale.
Da usarsi durante le ferie di questo tempo.
Questo prefazio fu inserito nell'ultima edizione del Messale Romano (1988). Ha un titolo dinamico e suggestivo. Presenta Dio come Padre ricco di misericordia, che prende l'iniziativa della nostra Salvezza perché "per il grande amore con il quale ci ha amati, da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo: per grazia infatti siete stati salvati. Con lui ci ha anche risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli, in Cristo Gesù" (Ef 2,4-6). Il prefazio presenta il cammino della Chiesa in Quaresima come un "nuovo esodo", nel quale la Chiesa è chiamata a fare penitenza e rinnovare la sua vocazione di popolo dell'alleanza nuova ed eterna, chiamato a benedire il nome di Dio, ad ascoltare la sua Parola ed a sperimentare con gioia le sue meraviglie.
Oltre a questi cinque prefazi numerati, ce ne sono vari altri, praticamente uno per ogni domenica, soprattutto nel Ciclo A.
La prima domenica s’incentra sulle tentazioni di Gesù nel deserto.
La seconda domenica sulla Trasfigurazione del Signore.
Le domeniche terza, quarta e quinta hanno alcuni prefazi chiaramente battesimali, in linea con le letture evangeliche, che presentano i grandi temi quaresimali dell'acqua (la samaritana), la luce (il cieco nato) e la vita (Lazzaro).
Come abbiamo già detto ci sono anche due prefazi di Passione, per gli ultimi giorni della Quaresima e Settimana Santa.
Sono undici prefazi in tutto. Possiamo usarli con profitto sia per la nostra predicazione sia per la nostra catechesi. In essi ci sono le idea-forza del mistero della Salvezza che si realizza nel nostro cammino quaresimale-pasquale.
d. Preghiere Eucaristiche.
Si possono usare le due preghiere eucaristiche sulla riconciliazione, soprattutto il mercoledì e il venerdì, che sono i giorni più penitenziali della Quaresima.
e. Introduzione al Padre nostro.
Per il tempo di Quaresima, può essere utile sottolineare nell’introduzione al Padre nostro l’invocazione: "Rimetti a noi i nostri debiti", oppure "Liberaci dal male".
f. Benedizione solenne e Orazioni sul popolo.
L’edizione del Messale Romano del 1988 ha inserito, per questo tempo, una benedizione solenne che nell'edizione precedente del Messale non esisteva. Per ciò sarà opportuno usarla soprattutto il mercoledì delle Ceneri e nelle domeniche di Quaresima.
Per le domeniche si possono usare anche le "orazioni sul popolo" riportate alla fine dell'elenco delle Benedizioni Solenni, e che sono le antiche benedizioni romane. Per le domeniche le più indicate sono quelle dei numeri 4, 11, 18, 20 e 21. Non bisogna dimenticare che la domenica VI di Quaresima o di Passione ha una benedizione propria.
Se si vuole usare qualcuna delle "orazioni sul popolo" durante i giorni feriali, le più appropriate sono quelle dei numeri 6, 10, 12, 15, 17 e 24. La 17 è molto indicata per il venerdì.
2. Programma dei canti.
-
a. Canto di entrata della messa.
Questo canto deve dare il tono quaresimale all'insieme della celebrazione eucaristica. Deve essere penitenziale o, al venerdì e nelle ultime due settimane, allusivo alla croce del Signore. Pertanto bisogna metterci molto cura nella sua scelta.
-
b. Salmo responsoriale.
Va sempre fatto quello proposto nella liturgia della Messa e non va sostituito a cuor leggero con un altro canto. Non ci stancheremo di dire che il Salmo è parte integrante della Liturgia della Parola; che è Parola di Dio, e che la parola divina non può essere mai sostituita con la parola umana.
Per quanto possibile si deve cantare. Se, però, l'assemblea non può cantare l'antifona propria del salmo della messa, si possono cercare altre antifone comuni, purché rispettino il senso del salmo.
Così, per esempio, si possono scegliere antifone penitenziali quando il salmo è penitenziale; o acclamazioni che alludano alla passione del Signore, quando il salmo suggerisca la preghiera di Cristo sulla croce.
Nel caso che nemmeno questo si possa fare è preferibile leggere il salmo, al quale l'assemblea risponde con l'antifona indicata, piuttosto che cantare una risposta che non ha lo stesso senso del salmo.
-
c. Acclamazione prima del vangelo.
Si possono dare questi suggerimenti:
-
È meglio riservarla unicamente per i giorni più solenni (domeniche e le prime tre ferie della Settimana Santa) ed ometterla nelle ferie.
-
Non deve essere mai cantata da un solista (non è un secondo salmo responsoriale, ma l'assemblea o un coro. L’ideale è che sia un canto vibrante ed un’acclamazione a Cristo che parlerà nel santo vangelo.
-
d. Canti di comunione.
Si dovranno evitare quelli che hanno dei riferimenti penitenziali, perché la comunione è sempre un momento festivo. Nel momento della comunione non si tratta tanto di creare un ambiente quaresimale, quanto di accompagnare festosamente la processione eucaristica. Perciò per questo momento della Santa Messa vanno scelti canti che alludono al banchetto eucaristico.
-
e. Preparazione dei canti della Veglia e dei cinquanta giorni pasquali.
Durante la Quaresima bisogna dedicare ogni settimana un tempo per provare i canti pasquali. Questo non solo per una necessità pratica in vista delle feste e del tempo liturgico che si avvicina, ma contribuirà anche a vivere la Quaresima come un itinerario verso la festa, creando il desiderio della sua celebrazione.
In questo senso, hanno tanta importanza sia le prove in sé come la spiegazione di alcuni testi cantati. In queste prove quaresimali si dovrebbe fare in modo che il repertorio pasquale cresca di anno in anno, così che i canti pasquali superino quelli degli altri tempi, così come la Pasqua supera in solennità le altre feste.
Tra i canti più importanti si potrebbero citare:
Un "Alleluia" vibrante, e magari nuovo che, ben provato dall'inizio della Quaresima, potrebbe impararlo bene tutta l'assemblea.
Un "Gloria" solenne e straordinario che si potrebbe inaugurare nella Notte santa di Pasqua e diventare il "Gloria" proprio del tempo pasquale, o per lo meno dell'Ottava di Pasqua. È buona cosa ricordare che il "Gloria" che si sceglie deve contenere nella sua totalità il testo liturgico del Messale Romano.
Chi canterà il "Preconio" nella Veglia Pasquale, dovrà provarlo con la sufficiente anticipo e non all'ultimo momento.
3. Preparazione del cero pasquale.
Il cero pasquale è forse il segno più tipico ed espressivo delle celebrazioni pasquali. Per ciò, non è sufficiente comprarne uno nuovo (sarebbe imperdonabile usare il cero degli altri anni, perché la Pasqua è la rinnovazione di tutto), ma è necessario preparare bene il luogo della sua futura presenza, e, ottenere che i fedeli l'anelino, perché rappresenta il Signore glorificato.
Suggeriamo, perciò, che la IVª domenica di Quaresima si organizzi tra i fedeli una colletta per acquistarlo. La IVª di Quaresima è la domenica della gioia nel cammino penitenziale verso la Pasqua e c'invita a pensare alla Pasqua come una celebrazione ormai molto prossima.
Così risulterebbe più vera l'espressione che si canterà nel preconio pasquale: "In questa notte di grazia accogli, Padre santo, il sacrificio di lode, che la Chiesa ti offre per mano dei suoi ministri, nella solenne liturgia del cero”.
È evidente che questa espressione perde tutto il suo significato se si usa un cero che è stato già, per così dire, "offerto" precedentemente.
4. Preghiera, mortificazione e carità.
Sono le tre grandi pratiche quaresimali o mezzi della penitenza cristiana (vedere Mt 6,1-6.16-18).
-
Innanzi tutto, c’è la vita di preghiera, condizione indispensabile per l'incontro con Dio. Nella preghiera il cristiano entra in dialogo intimo col Signore, lascia che la grazia entri nel suo cuore e, a somiglianza di Maria Santissima, si apre alla voce dello Spirito corrispondendovi con la sua risposta libera e generosa (vedere Lc 1,38). In questo tempo dobbiamo pertanto incoraggiare i nostri fedeli ad una vita di preghiera più intensa.
Per questo potrebbe essere consigliabile introdurre la preghiera delle Lodi o dei Vespri, nella forma che risulti più idonea: le domeniche o nei giorni feriali, come celebrazione indipendente o unita alla Messa; invitare i nostri fedeli a costituire un gruppo di preghiera che si riunisca stabilmente sotto la nostra guida, una volta alla settimana, per mezz'ora. In questo modo oltre a pregare possiamo insegnare loro a fare preghiera; incentivare la preghiera per la conversione dei peccatori, preghiera tipica di questo tempo; etc. Inoltre, non bisogna dimenticare che la Quaresima è tempo propizio per leggere e meditare quotidianamente la Parola di Dio.
Per ciò sarebbe molto opportuno offrire ai nostri fedeli il testo delle letture bibliche della liturgia della Chiesa di ogni giorno, nella speranza che la sua meditazione sia di gran aiuto per la conversione personale che ci è richiesta da questo tempo liturgico.
-
Anche la mortificazione e la rinuncia, nelle circostanze ordinarie della nostra vita, costituiscono un mezzo concreto per vivere lo spirito della Quaresima. Non si tratta tanto di creare occasioni straordinarie; piuttosto di offrire quelle circostanze quotidiane che più ci pesano; di accettare con umiltà, serenità e gioia, i vari contrattempi che ci si presentano nella vita quotidiana, approfittando di essi per unirci alla croce del Signore. Così pure, il rinunciare a cose pur legittime ci aiuta a vivere in modo più distaccato dalle cose. Il frutto di queste rinunce e sacrifici possiamo trasformarlo in elemosina per i poveri. Dentro questa pratica quaresimale ci sono il digiuno e l'astinenza.
-
La carità. Tra le diverse pratiche quaresimali che ci propone la Chiesa, la pratica della carità occupa un posto speciale. Così ce ne parla San Leone Magno: "questi giorni quaresimali c'invitano in modo urgente all'esercizio della carità; se desideriamo arrivare dalla Pasqua santificati nel nostro essere, dobbiamo mettere un interesse specialissimo nell'acquisizione di questa virtù che contiene in sé tutte le altre e copre una moltitudine di peccati". La virtù della carità dobbiamo praticarla in modo speciale con coloro che abbiamo più vicino, nell’ambiente concreto nel quale ci troviamo. Così, costruiremo nell'altro "il bene più prezioso ed effettivo che è quello della coerenza con la propria vocazione cristiana" (Giovanni Paolo II).
"C'è più gioia nel dare che nel ricevere" (Atti 20,35). Secondo Giovanni Paolo II, l’invito a dare "non è un semplice appello morale, né un comando che arriva all'uomo dall’esterno", ma "è radicato nel più profondo del cuore dell’uomo: ogni persona sente il desiderio di mettersi in contatto con gli altri, e si realizza pienamente quando si dà liberamente agli altri". "Come non vedere nella Quaresima l'occasione propizia per fare scelte decise di altruismo e generosità? Come mezzi per combattere lo smisurato attaccamento al denaro, questo tempo propone la pratica efficace del digiuno e l'elemosina. Privarsi non solo delle cose superflue, ma anche di qualcosa più, per distribuirlo a chi vive in necessità, contribuisce al rinnegamento di se stessi, senza il quale non c'è autentica prassi di vita cristiana. Nutrendosi con una preghiera incessante, il battezzato dimostra, inoltre, la priorità effettiva che Dio ha nella sua vita".
Per ciò, durante la Quaresima, sarà opportuno fissare, in base alla realtà delle nostre comunità, delle campagne a beneficio dei poveri, e vedere come incoraggiare i nostri fedeli alla carità personale.
La preghiera, la mortificazione e la carità, ci aiutano a vivere la conversione pasquale: ci fanno uscire dalla prigione dell'egoismo (peccato) e ci aiutano a vivere la dinamica dell'apertura a Dio, a noi stessi ed agli altri.
5. ASTINENZA E DIGIUNO
La pratica del digiuno, fin dall'antichità così legata a questo tempo liturgico, è un "esercizio" che libera volontariamente dalle necessità della vita terrena per riscoprire la necessità della vita che viene dal cielo: "Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio" (Mt 4,4; vedere Dt 8,3; Lc 4,4; antifona di comunione della I domenica di Quaresima).
-
In che cosa consistono l'Astinenza e il Digiuno?
L'astinenza proibisce di mangiar carne, ma non uova, latticini e qualsiasi condimento a base di grasso di animali. Sono giorni di astinenza tutti i venerdì dell'anno.
Il digiuno richiede di fare un solo pasto al giorno, ma non proibisce di prendere un po' di cibo al mattino e alla sera, attenendosi, per quanto riguarda la qualità e la quantità, alle abitudini locali approvate (Costituzione Apostolica Poenitemi, sulla dottrina e le norme della penitenza, III, 1,2). Sono giorni di digiuno ed astinenza il mercoledì delle Ceneri ed il venerdì Santo.
Con questi sacrifici, espressione di tutto il nostro essere (anima e corpo) riconosciamo la necessità di fare opere che riparano il danno causato dai nostri peccati e contribuiscono al bene della Chiesa.
Il digiuno e l'astinenza possono essere sostituiti da un altro sacrificio, in base a quello che stabiliscono le Conferenze Episcopali di ogni paese, perché spetta loro determinare le diverse forme di penitenza cristiana.
L'Astinenza può essere sostituita da:
-
pratiche di pietà (per esempio, lettura della Sacra Scrittura, Santa Messa, Preghiera del Sacro Rosario).
-
Mortificazioni corporali concrete.
-
Astensione da bevande alcoliche, tabacco, spettacoli.
-
Elemosina secondo le proprie possibilità. Opere di carità, etc.
-
Chi è chiamato all'astinenza ed il digiuno?
-
All'Astinenza dalla carne: i maggiori di 14 anni.
-
Al Digiuno: i maggiore di 18 anni fino ai 59 anni compiuti.
-
Perché il Digiuno?
Ci parla il Santo Padre:
«È necessario dare una risposta precisa a questa domanda, perché sia chiara la relazione tra il digiuno e la conversione, la trasformazione spirituale che avvicina l'uomo a Dio.
L'astenersi dal cibo e dalle bevande ha come fine di introdurre nell'esistenza dell'uomo non solo l'equilibrio necessario, ma anche il distacco da quello che si potrebbe definire “atteggiamento consumistico”.
Tale atteggiamento è diventato, nel nostro tempo, una delle caratteristiche della civiltà occidentale. L'atteggiamento consumistico! L'uomo, orientato verso i beni materiali, molto frequentemente abusa di essi. La civiltà si misura allora in base alla quantità e alla qualità delle cose che creano benessere all'uomo e non in base all'uomo.
Questa civiltà del consumo propone i beni materiali non solo per sviluppare le attività creative ed utili, ma anche e sempre di più per soddisfare i sensi, per I’eccitazione che da essi deriva, per un piacere momentaneo, una moltiplicazione di sensazioni ogni volta maggiore.
L'uomo contemporaneo deve digiunare, cioè, astenersi da molti prodotti di consumo, da stimoli, da soddisfazione dei sensi: digiunare, infatti, significa astenersi da qualcosa. L'uomo è se stesso solo quando riesce a dirsi dei no. Non è la rinuncia per la rinuncia: bensì per il migliore e più equilibrato sviluppo di se stesso, per vivere meglio i valori superiori, per il dominio di sé".
6. La Confessione.
La Quaresima è tempo penitenziale per eccellenza e pertanto si presenta come tempo propizio per spingere la pastorale di questo sacramento conforme a quello che ci ha chiesto recentemente il Santo Padre, poiché la confessione sacramentale è la via ordinaria per raggiungere il perdono e la remissione dei peccati gravi commessi dopo il Battesimo.
Non bisogna dimenticare che i nostri fedeli sanno, per una lunga tradizione ecclesiale, che il tempo di Quaresima-Pasqua è in relazione col precetto della Chiesa di confessare i peccati gravi almeno una volta all'anno. Proprio per questo, bisognerà offrire molta opportunità di confessioni.
7. La Quaresima e la Pietà Popolare.
La Quaresima è tempo propizio per un'interazione feconda tra liturgia e pietà popolare. Tra le devozioni di pietà popolare più frequenti durante la Quaresima che possiamo incoraggiare ci sono:
-
La Venerazione a Cristo Crocifisso.
Nella Triduo sacro, il venerdì Santo, dedicato a celebrare la Passione del Signore, è per eccellenza il giorno per la "Adorazione della santa Croce". Tuttavia, la pietà popolare desidera anticipare la venerazione cultuale della Croce. In realtà, durante tutto il tempo quaresimale, il venerdì, che è il giorno commemorativo della Passione di Cristo per antichissima tradizione cristiana, i fedeli rivolgono con devozione la loro pietà al mistero della Croce.
Contemplando il Salvatore crocifisso colgono più facilmente il significato del dolore immenso ed ingiusto che Gesù, il Santo, l'Innocente, ha sofferto per la Salvezza dell'uomo, e comprendono pure il valore del suo amore solidale e l'efficacia del suo sacrificio redentore.
Nelle manifestazioni di devozione a Cristo crocifisso, gli elementi abituali della pietà popolare come canti e preghiere, gesti come l'ostensione ed il bacio della croce, la processione e la benedizione con la croce, si combinano in modi diversi, dando luogo ad esercizi di pietà che a volte risultano preziosi per il loro contenuto e la loro forma.
Pur tuttavia, la devozione alla Croce, frequentemente, ha bisogno di essere illuminata. Va indicato ai fedeli il riferimento essenziale della Croce all'evento della Resurrezione: la Croce ed il sepolcro vuoto, la Morte e la Resurrezione di Cristo, sono inseparabili nella narrazione evangelica e nel piano salvifico di Dio.
-
La Lettura della Passione del Signore.
Nel tempo di Quaresima, l'amore a Cristo crocifisso dovrà portare la comunità cristiana a privilegiare il mercoledì ed il venerdì, soprattutto, per la lettura della Passione del Signore.
Questa lettura, di gran contenuto dottrinale, attrae l'attenzione dei fedeli tanto per il contenuto come per la struttura narrativa, e suscita in essi sentimenti di autentica pietà: pentimento delle colpe commesse (perché i fedeli percepiscono che la Morte di Cristo è avvenuta per la remissione dei peccati di tutto il genere umano ed anche dei propri); compassione e solidarietà con l'Innocente ingiustamente perseguitato; gratitudine per l'amore infinito che Gesù, il Fratello primogenito, nella sua Passione, ha dimostrato verso tutti gli uomini suoi fratelli; decisione di seguire gli esempi di mansuetudine, pazienza, povertà, perdono delle offese ed abbandono fiducioso nelle mani del Padre che Gesù ha dato in modo abbondante ed efficace durante la sua Passione.
-
La Via Crucis.
Tra gli esercizi di pietà coi quali i fedeli venerano la Passione del Signore, ce ne sono pochi tanto stimati quanto la Via Crucis. Attraverso questo esercizio di pietà i fedeli, partecipandovi col loro affetto, percorrono l'ultimo tratto della strada percorsa da Gesù durante la sua vita terrena: dal Monte degli Olivi, dove nell’ "orto chiamato Getsemani" (Mc 14,32) il Signore fu "preda" dell'angoscia (Lc 22,44), fino al Monte Calvario, dove fu crocifisso tra due malfattori (vedere Lc 23,33), al giardino dove fu sepolto in un sepolcro nuovo, scavato nella roccia (vedere Gv 19,40-42).
Attestazione dell'amore del popolo cristiano per questo esercizio di pietà sono le innumerevoli Via Crucis erette nelle chiese, nei santuari, nei chiostri e perfino all'aperto, in campagna o lungo la salita di una collina, alla quale le diverse stazioni conferiscono una fisionomia suggestiva. Nell'esercizio di pietà della Via Crucis confluiscono anche diverse espressioni caratteristiche della spiritualità cristiana: l’idea della vita come cammino o pellegrinaggio; come passaggio, attraverso il mistero della Croce, dall'esilio terreno alla patria celeste; il desiderio di unirsi profondamente alla Passione di Cristo; le esigenze della sequela di Cristo, secondo la quale il discepolo deve seguire il Maestro portando ogni giorno la propria croce (vedere Lc 9,23). È quindi opportuno suggerire questa preghiera nei mercoledì e/o venerdì di quaresima.
8. La Vergine Maria in Quaresima.
Nel piano salvifico di Dio (vedere Lc 2,34-35) il Cristo crocifisso e la Vergine addolorata sono associati. Come Cristo è l’ "uomo dei dolori" (Is 53,3), attraverso il quale Dio si è degnato di "riconciliare a sé tutti gli esseri: quelli del cielo e quelli della terra, facendo la pace per il sangue della sua croce" (Cavolo 1,20), così Maria è la "donna del dolore" che Dio ha voluto associare a suo Figlio, come madre e partecipe della sua Passione. Dai giorni dell'infanzia di Cristo, condividendo il rifiuto cui era oggetto suo Figlio, tutta la vita della Vergine trascorse sotto il segno della spada (vedere Lc 2,35).
Per ciò la Quaresima è tempo opportuno anche per crescere nel nostro amore filiale a Colei che ai piedi della Croce ci consegnò suo Figlio, e sacrificò se stessa con Lui, per la nostra salvezza. Questo amore filiale possiamo esprimerlo durante la Quaresima promuovendo alcune devozioni mariane propri di questo tempo: "I sette dolori di Santa Maria "; la devozione alla "Madonna addolorata" la cui memoria liturgica la si può celebrare il venerdì della Vª settimana di Quaresima; e la preghiera del Santo Rosario, specialmente i misteri dolorosi.
Possiamo promuovere il culto della Vergine Maria anche attraverso la celebrazione di Messe della Beata Vergine Maria i cui formulari di Quaresima possono essere usati il sabato.
V. NORME LITURGICHE COMPLEMENTARI
1. Mercoledì delle Ceneri.
La benedizione ed imposizione della cenere si fa dopo il vangelo e l'omelia. A motivo di questo rito penitenziale, iniziando la messa di questo giorno si sopprime l'atto penitenziale. Perciò, il celebrante dopo aver baciato l'altare, saluta il popolo e, di seguito, può dire le invocazioni, "Signore pietà", (senza anteporre altre frasi, perché oggi non sono atto penitenziale), e la preghiera-colletta, passando poi alla liturgia della parola.
Dopo l'omelia si fa la benedizione e l’imposizione della cenere; finita questa, il celebrante si lava le mani e continua la celebrazione con la preghiera dei fedeli.
2. Domenica IVª di Quaresima.
Essendo la domenica della gioia durante l’itinerario quaresimale verso la Pasqua, durante tutta la domenica IVª (dai I Vespri che si celebrano il sabato precedente), è conveniente mettere fiori sull'altare e suonare l’organo durante le celebrazioni. In questo modo si fa comprendere ai fedeli che è vicina la gran festa della Pasqua e che il frutto del nostro sforzo quaresimale sarà quello di risorgere col Signore alla vita vera.
3. Ferie della Vª Settimana di Quaresima.
Le ferie della Vª Settimana di Quaresima - antica settimana di Passione - hanno alcune piccole caratteristiche proprie: senza smettere di essere tempo di Quaresima, assumono già qualcosa del carattere proprio della prossima Settimana Santa e con ciò inaugurano, in un certo qual modo, la preparazione del Triduo Pasquale, portandoci alla contemplazione della gloria della croce di Gesù Cristo.
È conveniente non dimenticare di dire, nella messa, tutti i giorni, il prefazio I° della Passione del Signore.